di Ornella Cioni da Articolo21.org
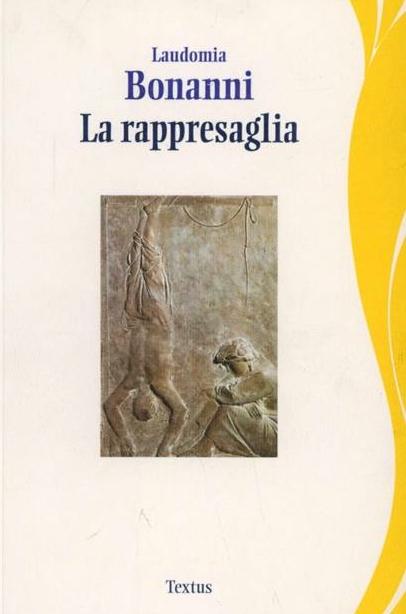 In prossimità del 25 aprile può essere interessante la lettura de La rappresaglia di Laudomia Bonanni (1907 – 2002), un romanzo che da Giulia Caminito è stato definito “non semplice né per temi né per la scrittura. Affrontare la Resistenza da una posizione poco comune chiama in causa il terrore del revisionismo da una parte e dall’altra ferisce la narrazione compatta che la letteratura aveva dato della guerra e dei fascisti”*.
In prossimità del 25 aprile può essere interessante la lettura de La rappresaglia di Laudomia Bonanni (1907 – 2002), un romanzo che da Giulia Caminito è stato definito “non semplice né per temi né per la scrittura. Affrontare la Resistenza da una posizione poco comune chiama in causa il terrore del revisionismo da una parte e dall’altra ferisce la narrazione compatta che la letteratura aveva dato della guerra e dei fascisti”*.
Il testo ha una complessa gestazione e una controversa storia editoriale. Bonanni riceve un primo rifiuto alla pubblicazione di Stridor di denti nel 1949 da Mondadori che non lo ritiene all’altezza del libro di racconti Il fosso, che precedentemente aveva pubblicato e che aveva portato la scrittrice alla notorietà. L’autrice lavorerà incessantemente a questo testo per anni. Diversi studi hanno individuato un filo che unisce per luoghi, personaggi, azioni Stridor di denti, il racconto Seme e due elzeviri pubblicati nel quotidiano romano “Il Giornale d’Italia” (1952 – 1955), quasi particelle del manoscritto La rappresaglia.
Nel 1985 Bonanni propone la pubblicazione de La rappresaglia a Bompiani che lo rifiuta, giudicandolo non adatto al pubblico dei suoi lettori. Se il primo rifiuto di Stridor di denti potrebbe essere attribuito a uno stadio ancora acerbo della prima stesura, dopo quasi quarant’anni di lavoro appare più strano il rifiuto di Bompiani, un editore a cui l’autrice aveva fatto vincere diversi premi. La delusione di questo nuovo diniego è forte, genera rabbia e frustrazione nella scrittrice che, nonostante i molti successi, non aveva saputo adeguatamente sfruttare la raggiunta notorietà nel difficile ambiente degli intellettuali romani, in cui non si era mai del tutto inserita. Lei, che è colpita spesso da crisi di nervi e da periodi di depressione, decide di non scrivere più e di ritirarsi dalla vita culturale pubblica.
La rappresaglia verrà pubblicata postuma nel 2003 dall’editrice aquilana Textus che in tempi recenti ha proposto in un unico volume Il fosso e La rappresaglia, le opere che segnano l’inizio e la fine della parabola della scrittrice, che hanno importanti legami circa i temi e in cui si può individuare l’evoluzione di alcune significative parole – metafora, come ad esempio “il fosso”.
Ne La rappresaglia la vicenda si dipana in prima persona narrata da una figura maschile, un maestro, che è un personaggio in posizione anomala, interno alla storia, ma a volte come esterno, testimone che osserva, fa parte del gruppo di fascisti da cui spesso prende le distanze e con cui condivide una tessera presa senza convinzione, ma non porta armi e non agisce.
Il luogo è un eremo sui monti dell’Abruzzo dove si rifugia un gruppo di sbandati fascisti, sotto copertura dei tedeschi, per sfuggire ai partigiani. Subito dopo il loro arrivo nel rifugio tra i monti catturano una partigiana quarantenne in avanzato stato di gravidanza: “Non era giovane: due ferze bianche alle tempie e la faccia duramente segnata intorno alla bocca. Stavano tutti a fissarla, a seguire le mani che respingevano l’ammantatura. Come se si scoprisse un monumento. Era un monumento. Quando si tolse il panno dalle spalle buttandolo giù, si vide il ventre. E sembrò enorme”. Anche la massa di “capelli mozzi che si drizzavano come serpi” la fa apparire come una Medusa, infatti la Rossa, come verrà chiamata, non si fa intimidire e non appare affatto docile né spaventata. Una delle scene più iconiche e drammatiche è quella del processo che viene istruito nottetempo nel coro della chiesa diroccata: la donna è condannata a morte, ma si aspetterà che partorisca per ucciderla. Poco dopo arriva di passaggio all’eremo un giovane prete, che messo al corrente della situazione, decide di fermarsi per assistere la prigioniera. Tutta la vicenda, narrata nella prosa aspra e incalzante dell’autrice, si svolge nell’attesa della fucilazione. Come dice Caminito: “La rappresaglia ha una scrittura a semina: sono sparsi per il romanzo particolari e rimandi. Accostarli e riprenderli sta allo sforzo di chi legge”**.
Nella lunga attesa del parto la convivenza, le lunghe giornate vicino al fuoco darà occasione di scambi, di bruschi dialoghi fra la prigioniera e gli uomini. Ma solo fra la Rossa e il giovane prete si stabilirà un vero dialogo, non privo di tensioni, soprattutto di fronte ai tentativi di conversione del prete. Attraverso i loro discorsi apprenderemo qualcosa della storia della Rossa: le sue origini in una misera periferia, il dover imparare l’italiano a scuola come fosse una nuova lingua, il lavoro di serva durante il quale rubava libri e giornali, il suo desiderio, realizzato, di uscire dall’ignoranza fino a raggiungere un” bel diploma gialliccio con i ghirigori azzurri”. La Rossa racconta anche agli uomini un sogno ricorrente in cui si sente imprigionata in un bastone da cui riesce a scorgere l’esterno con un solo occhio: il sogno allude all’ossessione a una vita privata degli strumenti della cultura per pensare e agire la libertà, condizione in cui si trova la maggior parte delle donne. Ma lei ha lottato, è riuscita ad andare oltre e torna la parola metafora “fosso” in una delle sue invettive in cui spiega la sua storia e i suoi obiettivi: “Ero uscita dal fosso e volevo aiutare tutti ad uscirne”, nonostante per questo anche lei abbia dovuto uccidere. Le figure maschili sono figure deboli tanto che di loro dirà: “Morire per mano di questi poveri sbandati, gente che neppure sa perché si batte”.
Divisi tra il desiderio di tornare alle loro occupazioni paesane e il richiamo al ruolo che hanno assunto, hanno opinioni politiche confuse; si sono lasciati facilmente coinvolgere in violenze – “Sei stato un prepotente” rimprovera una delle mogli al marito – e si sono “infanatichiti” per la guerra. Nell’attesa del parto la decisone di ucciderla vacillerà, ma ogni volta la spinta ideologica riporterà gli uomini alla loro decisione, inutile il tentativo di dissuaderli del prete e l’accorata perorazione di una delle mogli venute a portare provviste e notizie dal paese. Le donne ripartiranno con la raccomandazione di tenere quel poco di caffè e di zucchero che avevano portato per la partoriente e la neonata. La Rossa con i suoi atteggiamenti provocatori sembra all’inizio rifiutare la gravidanza che porta avanti. Quando la catturano sfida gli uomini che l’hanno apostrofata volgarmente: “Su, bucatemi subito. Qui dovete sparare, farne un crivello di questo ventre di puttana con tutto quello che c’è dentro. Seme d’uomo, ah, ah. Voglio strapparmelo con le unghie questo frutto della vostra razza schifosa d’ipocriti maschi …”.
Diventa una figura quasi mitica che compie un rito misterioso quando vuole affrontare il parto completamente sola chiusa nella cella, mentre il prete prega e gli uomini sono completamente disorientati . “Gli uomini restavano a bocca aperta, una scura costernazione in faccia. Non è naturale. Che una donna partorisca in silenzio e voglia restare sola, così rinchiusa, non è naturale”. E mentre aspettano “Stettero nel gelo scuro del corridoio, addossandosi in ascolto con aria derelitta. Veniva da dentro un ruglio profondo, come di bestia infuriata. Durò un’eternità. Quando tacque tutte le facce erano pallide e stravolte”.
Nasce una bambina e la Rossa trova una nuova consapevolezza che è anche una speranza: “ … il mio tempo breve credo di non averlo sprecato, lascio una vita e un seguito”. Ancora quando si avvicina l’esecuzione, in uno dei rabbiosi dialoghi col prete, dichiara la sua nuova consapevolezza: “Sì, questa orribile femmina che hai davanti ama l’umanità più di te. Tutta, te perfino … Anche la rivoluzione è oscena e sanguinaria per amore. È invasata per amore. La rivoluzione è femmina, partorisce da sola come me. Ah, ah, io sono la rivoluzione. Tu l’hai capito, perciò non hai voluto salvarmi, lo so, la vendetta è tua”. Se nella prima fase della maternità respinta il seme, parola – concetto, equivale alla concezione del seme maschile come generatore del male, alla fine c’è un’evoluzione e il seme che ha generato è l’unica speranza che rimane e sopravvive alla guerra.
Dopo la narrazione contratta e tragica dell’esecuzione il narratore/testimone continua il racconto. Figura complessa e contraddittoria, alter ego di Bonanni – anche lei maestra e con rapporti con il fascismo da cui entrambe hanno poi preso le distanze – e metafora dello scrittore in generale: volevo raccontare la vita, le passioni e le angosce, la guerra e il sangue. Portavo in me la voglia di scrittore, che guarda tutto e tutto immagazzina e macina… Da spettatore. Lo scrittore è un impavido spettatore. Un guardone psicologico. Ed è stato il mio modo di farmi coinvolgere dalla vita”. Poi è colto da dubbi, approfondisce la sua posizione: “A momenti, se provo a rileggere, non so più distinguere il vero dal fantasticato. La realtà va in ombra e i fantasmi prendono corpo. In questa osmosi forse è l’arte. È questo il piacere della creazione. Forse sono uno scrittore”.
Del gruppo di sbandati tornati infine in paese egli racconta come sono vissuti e morti scontando quell’esecuzione in una specie di contrappasso. Nessuno di loro ha generato, nemmeno il narratore, che come scrittore ha tuttavia percorso la strada di un altro generare : “Io scomparirò, ma che restino le carte. Voglio salvarle … Da pubblicare. Dopo morti si è accettati. E magari meditati. … benché la storia rimanga aperta, mai un libro è finito. Ma che fine ha fatto la bambina?”.
- Giulia Caminito, Amatissime, Giulio Perrone editore, pag.137
- Giulia Caminito, ibidem, pag.138





