di Anna Rita Bellini
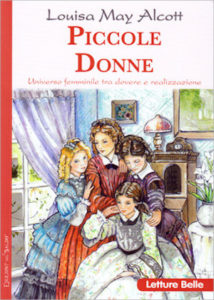 Ho letto “Piccole donne” da bambina, all’incirca a nove anni; mi piacque molto quella casa piena di libri, di letture, di teatrini. Scoprii che la povertà non faceva rima con ignoranza, anzi poteva contenere il germe del riscatto sociale attraverso i libri; soprattutto mi attiravano la conoscenza e il sapere che aleggiavano nella casa dignitosamente modesta delle sorelle March.
Ho letto “Piccole donne” da bambina, all’incirca a nove anni; mi piacque molto quella casa piena di libri, di letture, di teatrini. Scoprii che la povertà non faceva rima con ignoranza, anzi poteva contenere il germe del riscatto sociale attraverso i libri; soprattutto mi attiravano la conoscenza e il sapere che aleggiavano nella casa dignitosamente modesta delle sorelle March.
E come una calamita mi attirava Jo, spigliata, intraprendente, anelante libertà di pensiero e di costumi, pronta al sacrificio senza farsi compiangere, triste e addolorata soltanto quando gli altri non potevano vederla.
Jo volteggiava nella mia testa insieme alla sua coda di capelli, talmente belli da poter essere venduti.
Jo mi faceva sentire forte e mi insegnava, insieme alle sue sorelle, la bellezza del fare, dei piccoli lavori che, oltre a tenere le mani occupate, garantivano un minimo di autonomia: il lavoro per essere decorosamente libere.
Jo sapeva dire di no alle imposizioni, all’autorità ed era in grado di rifiutare anche l’amore; questo mi lasciava un po’ dubbiosa… Si poteva rifiutare un bel ragazzo?
Jo era ribelle, quindi… forse si poteva, oppure si poteva amare mantenendo la propria libertà e indipendenza.
Troppo piccola allora per darmi una risposta.
Ma il seme di Jo covava nel cuore e la sua bellicosità e autodeterminazione vennero alla luce qualche anno più tardi, quando l’insegnante di lettere al ginnasio, dopo un’ora trascorsa a decantare le virtù della Lucia manzoniana, cheta, mansueta e pudica, chiese alle sue alunne : “Quale personaggio dei Promessi Sposi vorreste essere?”.
Alzai fiera la mano dicendo: “La monaca di Monza!”.
L’insegnante sbiancò.





